I brani che seguono, qui pubblicati in assoluta anteprima, sono tratti dal mio Sogno della giungla, un progetto metaletterario che ha preso corpo intorno all’idea di scrivere un’opera di narrativa utilizzando esclusivamente la tecnica del cut-up.
Come sapete, il cut-up è un metodo di composizione letteraria basato sul montaggio, che consiste nel tagliare un testo preesistente (altrui o proprio) e ricombinare i suoi elementi (parole o frasi) dando vita a un testo nuovo.
Secondo le istruzioni di Tzara, che inventò il cut-up nel 1921, il taglio del testo di partenza va eseguito fisicamente: il libro-fonte deve essere ritagliato con le forbici e poi ricostruito, come in un collage.
Anche io ho fatto più o meno la stessa cosa, ma con lo scanner e Photoshop: acquisita una scansione di tutte le pagine dei miei libri-fonte, ho usato il software per ritagliare le parole e incollarle su un documento vuoto in una sequenza diversa dall’originale.
Il mio primo libro-fonte è stato 45° all’ombra. Dalla Città del Capo al lago Tanganica, 1935, di Orio Vergani; direi anzi che devo l’intuizione del cut-up proprio alla lettura di questo libro, e ai sentimenti contrastanti che ha suscitato in me la rappresentazione dell’Africa e degli africani che vi è contenuta.
Scritto mentre l’Italia fascista si preparava a invadere l’Etiopia proclamando l’Impero, destinato a una collana popolare (Viaggi e Paesi dell’editore Treves, che spaziava dalle spedizioni polari alle gite gastronomiche), 45° all’ombra non è un esempio di letteratura divulgativa o, peggio, propagandistica: è un documento etnografico prodotto da un autore raffinato e colto; senza dubbio viziato dall’orientamento essenzialista proprio del suo tempo, ma animato da una tensione poetica non comune.
La prima pagina che ha colpito la mia immaginazione descrive l’arrivo di Vergani in Africa, al termine di un lungo viaggio in nave: il continente sconosciuto gli appare come un mondo alieno, “un nuovo pianeta”; è una visione quasi orfica, che lo esalta e lo riempie di ansia.
Il linguaggio è ricercato ma carico di autentica tensione; l’aggettivo più ricorrente è “barbarico”: come in Campana, e anche in Pasolini.
Notavo che, se avessi trasferito le parole di Vergani in un contesto diverso, cioè se avessi eliminato ogni riferimento storico, avrei ottenuto un racconto di fantascienza: da questa osservazione è nata la prima immagine del Deserto Rosso, il deserto radioattivo.
Avevo lo stesso pensiero anche riguardo al modo in cui in 45° all’ombra sono ritratte le persone: è chiaro che gli africani esercitano sull’autore un fascino potente; che ne è respinto ma anche attratto, come dagli esemplari prodigiosi di una razza venuta dallo spazio. Da qui vengono i Mutanti, esseri dotati di facoltà che li rendono immuni all’aria contaminata del deserto.
Hanno squame colorate sul dorso, sullo stomaco e sui fianchi, e piccole ali marine alle costole, che i vecchi non sembrano avere. Resto a guardarli a lungo, preso da una sorta di nostalgia.
Così ho composto i primi cut-up: ritagliando le frasi che mi sembravano più adatte a rovesciare il realismo di Vergani in una specie di fantascienza critica.
Avevo ancora in mente Campana; pensavo a una specie di versione post atomica dei Canti Orfici, e volevo usare 45° all’ombra come lessico: un olocausto nucleare ha spazzato via la civiltà; un narratore solitario ne contempla le rovine, riferendo le proprie devastanti esperienze interiori.
È stata la scoperta del tutto casuale del mio secondo libro-fonte, Hermaphrodito, 1918, di Alberto Savinio a spingermi a elaborare una trama, e a usare il cut-up per scrivere un racconto vero e proprio.
Hermaphrodito si presenta di per sé come un collage, una sorta di frammento gigante assemblato con materiali precedentemente pubblicati da Savinio su varie riviste, in italiano e in francese: è una parodia priva di finale, un non-romanzo, un insieme le cui parti hanno pieno senso solo se combinate; è anche un esempio mirabolante di plurilinguismo, dove la varietà e le invenzioni linguistiche riescono a evocare in modo particolarmente intenso il caos che faceva ribollire il Mediterraneo durante la Prima guerra mondiale.
La scena toccante dei piccoli figli dei pescatori che fanno il bagno al porto di Taranto ha fornito l’ossatura per il capitolo sugli Zoidi, i misteriosi cloni impiegati dai superstiti della catastrofe per i lavori più ingrati.
Approfitto per chiarire che tutte le parole utilizzate nei cut-up (anche appunto “zoidi”) sono state trovate nei testi di partenza: infatti nessun termine è stato da me aggiunto al lessico ricavato dai libri-fonte.
Non posso non citare una terza opera letteraria che, sebbene non abbia fornito alcun materiale ai cut-up, può essere ben considerata alla stregua di un libro-fonte per l’influenza che ha avuto sulla trama: Mafarka il futurista, 1909, di Filippo Tommaso Marinetti, incredibile romanzo fantascientifico ambientato in un’Africa trasfigurata, fuori dal tempo; la scelta di Alessandria come sfondo per la mia storia è un omaggio a Marinetti, che in quella città era nato.
Ho affrontato i libri-fonte con la minor soggezione possibile, facendomi forte di quel diritto di proprietà che ogni lettore detiene nei confronti delle opere che ama e che non ama; ho affrontato il cut-up come un esperimento di autocoscienza, o una seduta di meditazione.
William Burroughs sosteneva che i cut-up potessero servire a predire il futuro, come una forma di divinazione: dobbiamo sperare che avesse torto; e che il futuro intravisto in questo “Sogno della giungla”, pure paurosamente plausibile, sia solo un’angosciosa fantasia.

[cut-up da Orio Vergani, 45° all’ombra, Treves, Milano 1936]
IL DESERTO ROSSO
Riverbero rossastro di sabbie senza termine; rombo costante di tuono dal cielo viola.
Nuvole: abbaglianti, stese in file parallele.
Nuvole di cavallette: immobili, simili a enormi macchie dorate sospese nel vuoto.
Giravolte della pista di polvere, come voli d’ali.
Lungo le grandi moli aride, relitti abbrunati di ruggine in fila ad aspettare di diventare polvere anch’essi.
Brevi trafori scavati dal vento.
Laghi chimici, di un verde lattiginoso; vapori esalano fetidi dal terreno bollente.
I MUTANTI: UOMINI CAVALLO
Colossi d’ebano dal passo lungo, con calcagna paurose, membri di bronzo bagnato.
Zigomi alti, denti bianchi e affilati, labbra di un rosa freddo.
Diffidenza degli occhi: occhi pieni di mosche, lucidi di febbre.
I MUTANTI: UOMINI RONZINO
Ginocchia secche, aride, grossi ventri tesi; guance scavate, da digiunatori, bocche color uva.
Crani di lana nera; occhi di smalto, dal tristo splendore.
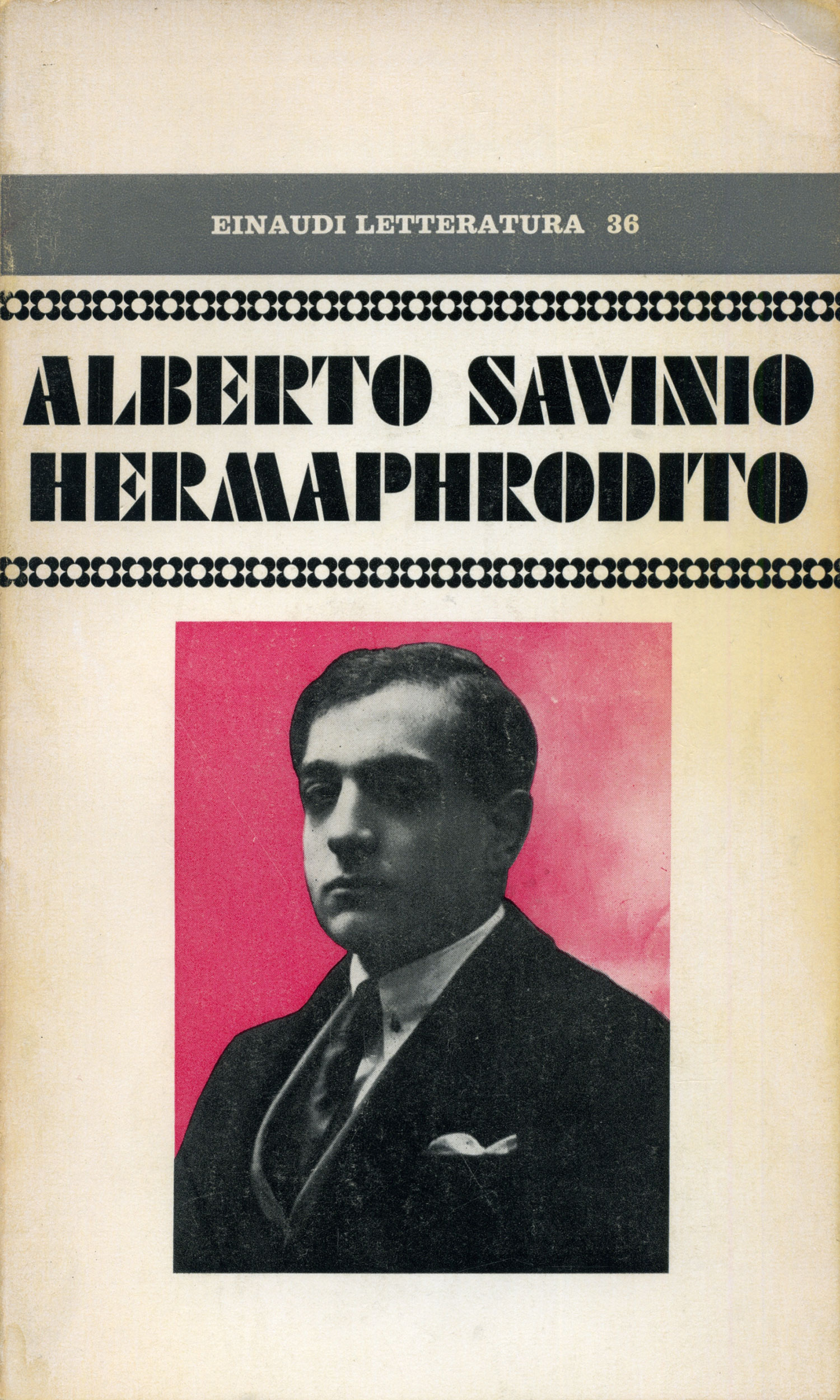
[cut-up da Alberto Savinio, Hermaphrodito, Einaudi, Torino 1974]
ALESSANDRIA
Il sole si leva.
Ecco finalmente la città, distesa entro un nastro di nubi ribollenti, miracolosa come un’isola volante che galleggia sul paesaggio anemico.
Essa è nuda dinanzi alla vuotezza terribile dello spazio: un punto incalcolabilmente piccolo che brilla sullo specchio lucido del deserto, una traccia più luminosa nello sfondo di sabbia.
Fa pensare a una stella imprudente, che si sia staccata dal firmamento immenso e sia precipitata quaggiù.
Il volume delle nubi ha la forma solenne di un anello: immagino colonne di uomini che vi girano attorno; mi sembra di vederli, oscenamente vivificati dal sangue della terra morsa, come figli che una madre, nel viluppo dell’angoscia, richiami a mordere la propria carne.
Questa è dunque la forza che moltiplica i germogli: la fecondità terribile del corpo denutrito del mondo, votato – malgrado tutto – alla procreazione; il fermento della vita, consacrato all’ineludibile travaglio del tempo.
GLI ZOIDI
La manutenzione delle macchine inerti si compie durante il giorno.
Lungo la banchina vedo giungere una fila di zoidi anziani, senili: omuncoli neri, tutti straordinariamente somiglianti tra loro, come tanti gemelli.
Avanzano taciturni e ritti, con uno spostamento di gambe così debole che sembrano scivolare sull’asfalto.
Pazientemente cominciano ad asciugare i fusibili ancora bagnati dalla notte precedente, a ingrassare le ruote corrose dal moto, a far scendere gli stantuffi.
Sono vestiti come soldati, con l’uniforme lurida, i gambali logori; e come i soldati sono obbligati ad assentire, a sporcarsi le mani, ad accettare la fatica che li annienta lentamente, ad accettare tutto.
Non fanno obiezioni, non hanno volontà che per quei gesti sempre uguali, che riproducono come in un rito, in balia della loro molle incoscienza.
Tale processo, continuamente ripetuto, li conduce di quando in quando ad una visibile frenesia, che si manifesta con uno spasimo intenso dei muscoli e dei nervi: una frenesia che pare ira, ma altro non è che l’espressione della loro meraviglia, dello stupore che quegli esseri negletti provano per il solo fatto di essere al mondo.
È una foga che li sfibra e li esaurisce, rivelando tutta la goffa mitezza della loro tempra.
Come la fosca magia di costoro non appartiene alla verità semplice della creazione, al buio originario, ma alla logica di uno scienziato, così la loro salute appartiene a noi, al nostro appetito secolare, alla nostra grottesca sete di traffici.
D’improvviso scorgo una dozzina di maschi giovani: si precipitano lungo il canale traboccante di putride bolle, corrono alle vasche colme di acqua ragia, sguinzagliati e nudi; semplicemente e stupendamente nudi.
Non resisto alla curiosità: provo un bisogno divorante di guardare, di conoscere, di imparare, e così li seguo.
Li osservo mentre uno dopo l’altro si tuffano e guizzano sul fondo, a pescare fra i detriti piccoli pezzi di zinco e di rame; emergono, sorgono dall’acqua carica di iridescenze, densa di sostanze corrosive; si issano sui pilastri, lucenti nella pelle ocra bruciata, lottano, strillano e si rituffano: fradici di luminosità smaglianti, scintillanti e sinuosi, come farfalle meccaniche.
Hanno squame colorate sul dorso, sullo stomaco e sui fianchi, e piccole ali marine alle costole, che i vecchi non sembrano avere.
Resto a guardarli a lungo, preso da una sorta di nostalgia.
Sono commosso dal miracolo della vita artificiale, turbato dall’enigma di quella razza concepita sulla lente di un microscopio, nutrita nel ventre liquido della scienza, nata dall’accordo avventuroso di inspiegabili chimismi: una fantasmagoria di formule, capace di sviluppare i tessuti ma anche di mitigare l’indole, formando gli zoidi all’obbedienza, al loro destino di servi; teorie ormai dimenticate, diramanti da quell’abitudine alla deduzione che una volta segnava la superiorità dell’uomo sulla restante fauna terrestre.
C’è un’affinità palese tra la verde innocenza degli zoidi giovani e l’ingenuità santa degli anziani; mi sembra difatti che gli anziani, nonostante l’idiota rigidezza dell’aspetto, conservino nelle anatomie un che della purezza di quella gioventù, della sua candidezza fatale.
Anzi, non so se questi esseri si possano dire vecchi, o ragazzi: cioè se pure nell’esistenza degli zoidi, come nella nostra, ci siano di fatto un’infanzia, un’età matura e una vecchiaia, oppure no.
Sono tanti, macabramente simili uno all’altro, come consanguinei, o apparizioni; tuttavia neanche la loro evidente inferiorità cerebrale mi persuade che siano meno che umani.
Sulla nostra specie l’ambiente ha un’influenza profonda: di tale influenza, mi pare, risentono anche gli zoidi, ma oltre misura e ben più stranamente.
È la chimica che ha plasmato la misteriosa fisiologia di quegli organismi senza eguali: paradossali, imperfetti ma capaci di conservare se stessi, di sopravvivere a ogni furibondo sconvolgimento del clima, di mutare.
Mutare? Non tutto dunque è fatalità.
Rifletto: antichi calcolatori hanno tracciato il loro destino, con un’esattezza che non appartiene alla natura; ma non sarà forse stato un insolito avvicendamento di casi a condurre la precaria cerimonia degli esperimenti sino a tale esito magistrale? Un incidente insomma, che abbia acceso l’ineffabile luce della vita in quei corpi freddi, generati dai numeri.
E mi domando: chi creò gli zoidi era virtuoso e saggio? O era uno stolto senza scrupolo?
Certo è che le menti ottuse degli uomini contemporanei non potrebbero mai ripetere il trucco; del sapere del passato non rimangono che superstizioni e luoghi comuni.
Uno è quello per cui gli zoidi sarebbero sordomuti e privi di olfatto: per conto mio, ho riscontrato che esso è in effetti un luogo comune, poiché ho potuto intendere il verso acuto dei giovani chiaramente.
Allo stesso modo, davo per certo che gli zoidi fossero sterili; ma ora persino ciò mi pare opinabile. Al contrario, voglio insinuare il sospetto che non sia affatto questa la verità: altrimenti non saprei spiegarmi come possano essere così tanti, e per di più di età diverse.
Essi, di fatto, sono nostri prigionieri.
Camminano tra noi come stranieri, docili perché ineducati; per noi non provano che affetto e fiducia, ma ignorano che siamo tiranni: un giorno potrebbero comprendere che li abbiamo condannati a subire; che li abbiamo rinchiusi, e li abbiamo privati delle orecchie, così che non udissero le loro catene gridare tutta la nostra gelosia.
E se un giorno questi innocenti fossero liberati?
…Se si mostrassero ostili ai nostri occhi aperti alla paura…
E se infine il loro seme fosse fecondo?
Ciò spiegherebbe la lotta sostenuta dagli zoidi fino allo stremo per guadagnare un diritto di più alla vita: il loro cammino evolutivo sin da prima del disastro che ha dilaniato i continenti e sbaragliato l’ordine della storia; e il ciclo fantastico delle trasformazioni, le molecole che scoppiano di energia fredda, i muscoli elettrizzati dalla mutazione.
È l’istinto di conservazione che periodicamente li spinge a lasciare la pelle originale, a cambiare corpo per prevalere sulle proprie debolezze: così sono scampati illesi alla tragedia che ci ha travolti; e sono rinati ancora rinnovati, di volta in volta più adatti.
Non abbiamo ragione di crederli un nostro possesso: sono i discendenti degli uomini, il frutto di quest’ultima tremenda fioritura, e il futuro appartiene a loro.
[cut-up da Orio Vergani, 45° all’ombra, Treves, Milano 1936]
ALESSANDRIA
Crepuscolo lungo e stagnante.
Città animata da chiarori diffusi, confusa in un labirinto di fumi sottili.
Strana vecchiaia delle cose: che perdono peso, come illuminate da luci subacquee.
Processioni di poveri, a piedi scalzi sulla terra ancora rovente.
Silenzio delle voci; delle bocche in attesa di sfamarsi.
Silenzio profondo delle ombre, annidate qua e là tra le fosforescenze della sera.
[cut-up da Alberto Savinio, Hermaphrodito, Einaudi, Torino 1974]
Il cielo grasso, terribile di densità, si macchia del suo nero più cupo. Un nero minaccioso, che lentamente invade la città rianimandone il corpo metallico.
Il richiamo di una sirena risveglia i macchinari; le leve e i manubri -che per tutta la giornata restano fasciati nelle tele come dita malate- si ridestano nell’aria velenosa.
Si sente il fischio petulante delle pulegge rugginose che si rimettono a girare; l’urto progressivo delle catene che stridono, avvolgendosi nelle guaine di ferro allineate sui pontili, ai piedi della schiera disciplinata delle ciminiere che soffiano il loro ripugnante fiato gassoso nella vastità degli orizzonti liberi.


